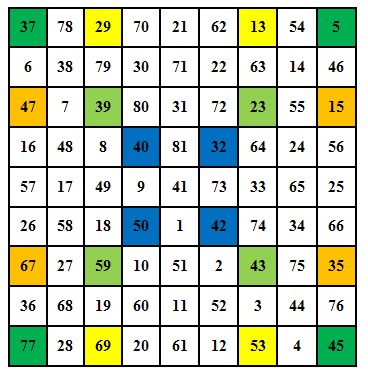le Idi di marzo
Le idi di marzo per rane dal pancino chiaro.
di Francesco Pasca
C’era una volta un orso.
No! Non era un orso ma uno gnomo, un elfo dei boschi.

No! Non era né un orso, né uno gnomo, né un elfo, ma, se fosse stato una di quelle cose o tutto quanto ho menzionato o supposto, da aggiungere fra il tanto, dirò concludendo che, c’era una volta un poeta a cui, come a me giunto attraverso uno scritto di Antonio Verri su («Sudpuglia», 1987, 1, pp.121-123), piaceva la dannazione e l’estasi del buon vino nonché conosceva dove: “imbottigliano «l'olio più dorato e più buono del mondo»”
Verri credo lo ascoltasse attentamente e, per questo scriveva: “tu che, come fosse la cosa più naturale del mondo, facilmente attraversi «montagne laghi colline/ draghi preistorici brughiere/ meravigliosi uccelli steppe/ lunghissimi tramonti/ rugiade albe emozioni segrete...”.
É sempre Verri che parla a Toma e gli farà dedica nel post-mortem con parole soffiate sul filo di una lama: “tu che insomma sai tante dannate e trasparenti cose, sai dirmi come mai fischiare sulla lama aiuta a mantenerla affilata?”.
Verri dunque doveva conoscerlo molto bene per azzardare con le sue «metamorfosi serali di cielo» in tempi segnati tra un diciassette ed un diciotto di marzo 1987.
Chissà se, il 15 di marzo data di quel calendario, Toma ne fosse stato presago, se sapesse che non vi sarebbero state per lui altre idi di marzo, né di maggio, di luglio o d’ottobre, né un tredicesimo giorno di altri mesi da non dover o voler dedicare al Dio della guerra, a Marte.
Chissà se avesse mai supposto di dover assistere ad altri assassinii-suicidi uguali e altrettanto efferati come quelli dal 44 a.C. in poi in cui i Bruto, i noi, i figli egoisti e trascurati, lo avrebbero poi ucciso con la non parola, con altra non poesia.
Le congiure per questi motivi si ordiscono.
Chissà se fra noi, in quei giorni, un altro noi, così come scritto per Cesare in Plutarco, non lo avesse avvisato: « … molti dicono che un certo veggente lo preavvisò di un grande pericolo che lo minacciava alle idi di marzo, e che quando giunse quel giorno, mentre si recava al Senato, egli chiamò il veggente e disse, ridendo, "Le idi di marzo sono arrivate"; al che egli rispose, soavemente, "Sì; ma non sono ancora passate" »(da Plutarco).
Di fatto quelle parole passarono inosservate sino a quel 17 di marzo.
Ma Toma non era tipo da volersi far molti sconti, solo pochi potevano, il resto del mondo o lo ignorava o era spettatore incosciente, agonizzante. Lui stesso si introiettava in questa figura d’uomo ed era pratica per dimenticare, per far consumare lentamente le delizie dell’egoismo con cui era sicuro di nutrire lui e gli altri uomini barbari, gli attori di un teatro perennemente fecondato dal dolore che non è mai pietà.
Se è vero che vi fu la certezza di un Tempo che avrebbe disfatto l’uomo, quest’ultimo è l’unico che non se ne sarebbe avveduto.
Per Totò Franz l’uomo, il maschio, è capace solo di vagliare il tempo delle cose o di rifiutarle oppure di imprecarle.
Per Totò il dramma dell’uomo non è l’essere stato Caino e al contempo Abele, ma di non esser stato mai Adamo e quindi suo figlio: Bevi, buffone, bevi! ogni sorso che ti scivola dolcemente nella gola è un’anima che muore lontano al buio; e tu, tu bevi per dimenticare? Vergogna! (Salvatore Toma)
Di Eva, della donna, della femmina ha invece il dolce ricordo di bambino uguale a quello per una madre, per una sposa, per un amante, per un figlio, e non importa se quest’ultimo sia maschio o femmina, è pur sempre un bambino, è nel fragile Tempo.
Ma “le rane hanno il pancino chiaro” e questa volta sono più d’una a gracidare nel parco dei poeti.
Chi ne stuzzica quel gracidare dopo la sua morte sono Antonio Verri e Maurizio Nocera e lo fanno in una edizione a blocco, in una cartella per fogli sparsi e per 199 esemplari. Il nome è “dopopensionante”, il tempo è il 1988, la dedica è al Poeta, è a Toma.
A me di quelle cartelle me n’è toccata una, mi dicono sia la prima.
I partecipanti al gran concerto del ’88 sono in settantuno.
Per il me che ha vissuto tutte le varie stagioni degli underground, del fuori termine di cultura o di tutti gli ampi insiemi di pratiche identiche ed accomunate è stato il voler testardamente continuare a porsi in antitesi e/o in alternativa alla cultura ufficiale.
In molti si domandano tuttora: Chissà mai cosa sarà stata, cos’è tutt’oggi quell’insistere e voler essere ufficiale, quel porsi nei ranghi del primo e del dopo?
Chiedere a Salvatore Toma cosa fosse mai la cultura ufficiale sarebbe stato il trangugiato di traverso, il suo non più “buon” vino.
Scorrere i fogli del “dopopensionante” è cantare, è avere, come leggo tra le righe di Aldo Bello, un’ascia in tasca che è un ghigno senza malizia per fare la propria vita a metà e vivere come giustizia, affrancare gli schiavi in fuga dal Sud e facilitare la fuga dei giovani che rifiutano la violenza, l’idiozia di un’arma.
Con la raccolta dei ben settantanove contributi si recupera in parte quello scarso interesse lamentato dai tanti pochi. Non credo che per Salvatore sia stato il supporre di doversene preoccupare, è sempre stato: “Buttate foglie sui morti”.
Il Quanto, il Come e il Chi, di lui, è stato scritto sulla scorza delle “sentinelle argentate” e, passeggiando per le vie della Messapia, si avverte nel centenario silenzio dei tanti o pochi (farà differenza?) che hanno saputo interpetrare quelle rughe, quelle forme sofferenti e contorte.
Nicola Carducci nel suo foglio per titolo: “congedo dalla poesia e dalla vita” esprime tra quelle rughe le tracce della spiccata presenza di Toma nella cultura salentina.
La Cataldini scrive: “ … Da un certo tempo in poi/ciascuno apre/la sua donna-uomo/batte il giocattolo/come il meccanismo/ai deletti di carta/alla luce del sole./ …”
La Camerini: “… l’uomo l’uomo dicono non sale/non depone uova/non si sa come bene non si sa/per quale personaggio autore agisce/in quei binari trinari …”
Per questo si volle “fabbricare”, e, a “fabbricare”, ci pensò Antonio Verri coadiuvato da Maurizio Nocera”.
Così nacque il Dopopensionante, foglio dopo foglio, pietra dopo pietra, giorni dopo giorni di fotocopiatura di contro-editoria.
Oggi è preziosa testimonianza elaborata da due amici e compagni di vita onirica, Antonio e Maurizio.
Oggi è documento epistolare, non è più fotocopia né lettera vecchia, è nota attuale di ricordo, è disegno perenne, è grafica poetica, è tuttora graffio alla cultura da baraccone, è sberleffo all’editoria da carta straccia per pulitura di vetri.
Leggere è respirare il poeta dalla robusta voce ma anche il mite poeta nel rapporto con gli amici, è anche l’altrettanto ribelle alle convenzioni, al conformismo, al fucile, allo schiaffo gratuito.
Maria Corti scrive sul suo foglio: «Salvatore Toma è una delle voci più originali e nuove della poesia meridionale. La sua incapacità ad adattarsi ad un ambiente di provincia e la scarsa solidarietà degli intellettuali locali hanno reso drammatica la sua esistenza».
Oggi anch’io scrivo di Toma, l’ho già fatto per caso o meglio per altre vicissitudini.
Lì, in quel mio improbabile essere scrittore ho appreso che vi sono ricordi e che vi è necessità di scrivere della rappresentazione del Tempo e del suo comportamento.
Ho appreso che in poesia il passaggio tra quei luoghi, tra i boschi affollati d’Arsapi, d’orsi, di elfi è l’obbligatorio e non il casuale.
Oggi scrivo di Salvatore perché l’ho raccolto tra le pagine di settantanove fogli, perché lì ho avvertito la sua paura di poeta, di chi va esprimendosi spontaneo e al contempo immensamente sprovveduto.
Scrivo perché è tuttora presente tra carta scritta il poeta provocatore, il sarcastico, l’allarmato nei confronti del mondo e dell’altrettanto mai paradossalmente strafottente.
Toma lo ritrovo autentico figlio del Sud e Iaccarino lo rammenta nel suo foglio: «… So che di certo stai sorridendo: non amavi la retorica degli addii, anche se pure tu hai pianto come oggi ti piango. Ci divide un imperfetto: tu eri, noi siamo. Noi sopravvissuti a vegliare la nostra pena. Ma anche questo tu non amavi: il peso del sacrificio …»
- Accedi per lasciare commenti